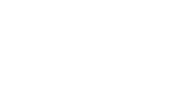Ettore Cinnella
La Collana degli Archivi di Stato
Rivoluzioni.
Una discussione di fine Novecento
a cura di D.L. Caglioti e E. Francia
E’ d’uopo esordire con alcune precisazioni terminologiche. Poiché parlerò di rivoluzione russa, di rivoluzione plebea e di rivoluzione bolscevica, devo chiarire che cosa intendo con tali espressioni. Generalmente per rivoluzione russa s’intende l’insieme dei tre distinti momenti rivoluzionari, quello del 1905 e gli altri due del febbraio-marzo 1917 e dell’ottobre 1917. Negli ultimi tempi è invalsa la moda di dilatare (e diluire) il processo rivoluzionario lungo un arco cronologico amplissimo, che va dalla fine dell’Ottocento fino alla morte di Lenin. Una simile operazione, se da un lato corregge la semplicistica e scolastica periodizzazione delle «tre rivoluzioni russe», corre il grave rischio di smarrire il carattere peculiare delle crisi rivoluzionarie le quali, per definizione, non possono non essere improvvise e dirompenti. Io propongo una diversa cronologia, che ha alcuni punti in comune con quella a suo tempo abbozzata da William Henry Chamberlin (uno dei più acuti conoscitori e narratori delle complesse vicende della rivoluzione russa, oggi caduto in oblio). Senza contare le numerose turbolenze politiche e sociali, che accompagnarono la storia della Russia dopo il 1861, la crisi esplose nel 1905 dando origine ad uno dei più grandiosi e complessi momenti rivoluzionari della storia moderna e contemporanea. La «prima rivoluzione russa», se così vogliamo chiamarla, fu un inestricabile intreccio di radicale rivoluzione liberale, ardite azioni di gruppi sovversivi e furiose lotte sociali, che squassarono l’immenso impero zarista ed ebbero una vasta eco anche nell’Europa occidentale. Quell’evento rivoluzionario attende ancora lo storico che ne racconti e analizzi i molteplici aspetti. In ogni caso, il 1905 non fu quella «prova generale» del 1917, immortalata dalla pubblicistica bolscevica e furtivamente accolta in tante ricostruzioni generali della storia della Russia nel Novecento. A parte il ruolo secondario svolto dal nascente bolscevismo, che non aveva né le radici popolari né l’acuta visione complessiva del partito socialrivoluzionario, nel 1905 fu fondamentale il momento liberale (tanto che, per una precisa fase della rivoluzione, si può finanche parlare di egemonia liberale); e, inoltre, l’intellighenzia democratica s’impegnò allora nella prodigiosa e difficilissima impresa di gettare un ponte tra le due Russie, ossia tra i ceti colti occidentalizzanti e le arretrate masse plebee.
Placatosi (non senza lasciar segni nella società e nel sistema politico) il gigantesco terremoto rivoluzionario del 1905-1907, continuarono nondimeno le scosse d’assestamento fino al 1917, quando in Russia la terra riprese a tremare in modo ben più cupo e pauroso. Solo gli eventi del febbraio-marzo 1917 ebbero una qualche somiglianza con le vicende rivoluzionarie del 1905. Poi, ben presto, gli avvenimenti presero un diverso e più convulso corso, portando in autunno alla vittoria bolscevica (ma non già alla fine della rivoluzione). Dopo alterne e complicatissime vicende, il processo rivoluzionario ebbe termine solo nell’estate 1921, allorché venne definitivamente sconfitta l’insurrezione contadina antibolscevica nella provincia di Tambov (la più vasta, e quella con il più netto profilo politico, fra le tante rivolte agrarie che squassarono la Russia sovietica nel 1920-1921). Le date, si sa, hanno soprattutto un valore simbolico. Ma, proprio per questo, se vogliamo sceglierne una a suggellare la fine della rivoluzione russa, dobbiamo a mio avviso indicare il 19 luglio 1921, quando furono revocate (perché ormai inutili) le crudelissime ordinanze grazie alla quali, mettendo a ferro e fuoco i villaggi ribelli e procedendo a fucilazioni sommarie, il generale bolscevico Tuchačevskij ebbe ragione della fiera opposizione dei contadini. Anche dopo Kronstadt, dunque, la cui epopea antibolscevica è a tutti nota, il movimento rivoluzionario rimase attivo ancora per qualche mese in vaste regioni della Russia.
Intendo per rivoluzione bolscevica, che viene spesso confusa con la rivoluzione russa, anzitutto l’esito bolscevico della rivoluzione del 1917, cioè la presa del potere da parte del partito di Lenin. Ma quest’evento fu solo un fatto politico, sia pure d’incalcolabile portata. In realtà, ci fu pure una rivoluzione sociale bolscevica, più difficile da analizzare e definire. Dicevo dianzi che non bisogna confondere la rivoluzione bolscevica con quella russa. Ma occorre altresì evitare di ridurre la rivoluzione bolscevica all’insurrezione d’ottobre, vista per giunta come un abile e spregiudicato colpo di stato. E’ facile dimostrare (ma io ora non posso farlo) che nell’autunno 1917 Lenin si rivelò un politico geniale non perché seppe organizzare al momento opportuno e nel modo migliore l’insurrezione armata a Pietrogrado (anzi, la sua isteria insurrezionalistica avrebbe portato il partito alla disfatta, senza il sagace e decisivo contributo di Trockij), ma perché colse con grande lucidità, più di tutti gli altri protagonisti della rivoluzione, la natura e l’ampiezza della furiosa jacquerie contadina allora in corso. In che cosa consisté, dunque, la rivoluzione sociale bolscevica? Essa coincise per alcuni aspetti con la rivoluzione plebea russa, nel senso che il partito di Lenin si fece portavoce delle istanze radicali degli strati più umili della società. Con l’afflusso di numerosi militanti plebei (soprattutto operai meno qualificati e soldati) sotto le bandiere del bolscevismo, il partito di rivoluzionari di professione fondato da Lenin subì anche sul piano sociale una profonda metamorfosi nel corso del 1917 e dopo la rivoluzione d’ottobre. I bolscevichi continuarono ad avere scarsi legami con le campagne, che simpatizzarono prima per i socialisti rivoluzionari e poi per i socialisti rivoluzionari di sinistra. Tuttavia, grazie al decreto sulla terra e al tempestivo (e temporaneo, occorre subito aggiungere) abbandono del vecchio dottrinarismo, il cui merito spettò a Lenin, il partito bolscevico riuscì a consolidare il potere conquistato con l’insurrezione a Pietrogrado. In tal modo, sia pure per pochissimi mesi, il bolscevismo si fece interprete dei bisogni e delle aspirazioni fondamentali della rivoluzione plebea contadina. Bisogna precisare (molti storici sembrano non essersene ancora avveduti) che furono i socialisti rivoluzionari di sinistra, alleatisi ai bolscevichi, a salvare la rivoluzione bolscevica e a consolidare il nuovo regime nelle campagne. Ma fu indubitabile, e si rivelò provvidenziale, la bravura di Lenin nel rinunciare (ancorché temporaneamente) alle viete posizioni ideologiche del marxismo russo, il cui maggior limite stava nell’incomprensione della vera natura dei rapporti sociali nelle campagne.
La rivoluzione plebea russa fu dunque il vasto sfondo sociale, che rese possibile sia la vittoria bolscevica nell’autunno 1917 sia il successivo esperimento sovietico. Si capisce ben poco della costruzione e della natura del sistema sovietico, se non si tengono presenti le sue radici sociali. La rivoluzione plebea fu una delle due forze fondamentali che plasmarono l’intera storia sovietica. L’altra fu il bolscevismo che, lo ripeto, sembrò per qualche mese e per taluni aspetti coincidere con la prima, ma che in realtà se ne differenziava profondamente, specie sul piano ideologico e politico. Cos’è il bolscevismo? Non è semplice definire un fenomeno storico che, malgrado la vasta mole della letteratura sull’argomento, resta ancora un oggetto per molti versi misterioso. Pur non essendo mio compito analizzarlo adesso, vorrei almeno ricordare che già il «leninismo» fino al 1917, ossia il più antico strato del bolscevismo, ad un’attenta analisi risulta formato da molteplici e contraddittorie componenti (il cosiddetto «marxismo russo», il socialismo della Seconda Internazionale, la tradizione cospirativa del populismo rivoluzionario, il bakunismo sociale, il mito dei soviet, per ricordarne solo le principali). Dall’ottobre 1917 alla morte di Lenin, il bolscevismo subì un’ulteriore metamorfosi ideologica, politica e sociale. Poi venne la fase staliniana dell’esperimento bolscevico, segnata da una netta impronta plebea e da vistosi caratteri totalitari. Quando, dopo la morte di Stalin, il regime totalitario decadde nell’Urss, il bolscevismo conobbe una nuova stagione sotto Chruščëv (il personaggio che, nella storia dell’Urss, forse piů di tutti impersonò sia l’ideologia bolscevica sia la natura plebea del sistema sovietico). Persino durante il plumbeo regno di Brežnev, quando pareva non fosse rimasto più nulla della dottrina bolscevica (esaltata nei discorsi ufficiali, ma lontanissima dalla realtà politica e sociale dell’Urss), Suslov riportò in auge la vecchia ideologia rivoluzionaria. Soltanto all’epoca di Gorbačëv, all’interno dell’Urss, nel bolscevismo non credeva più nessuno, neppure il segretario generale del partito; e forse non è un caso che, alla fine degli anni ‘80, si fosse esaurita anche la spinta propulsiva della rivoluzione plebea.
Ho detto prima che la commistione e l’interazione di bolscevismo e rivoluzione plebea plasmarono l’intera storia dell’Urss, dando vita alla società sovietica e al comunismo novecentesco. La spinta dinamica della rivoluzione plebea fu talmente possente da portare, negli anni ’30, alla nascita del primo stato plebeo della storia umana (uno stato governato da elementi provenienti dagli strati più umili delle classi lavoratrici). Tale carattere lo stato sovietico lo mantenne fin quasi alla sua dissoluzione, cioè fino all’avvento di Gorbačëv: a partire dagli anni ’30 i posti di comando nel partito e nello stato furono occupati da personaggi d’estrazione popolare. La grande spinta plebea dell’autunno 1917, combinandosi con l’azione politica del partito bolscevico, fu anche all’origine del totalitarismo sovietico. Narrare come ciò sia accaduto esula dal tema del mio intervento. Basti ora dire che il risultato fu la nascita d’una società dai tratti peculiarissimi, caratterizzata dalla singolare commistione di modernità e arcaismo. E’ a tutti noto che la società sovietica conobbe un processo di rapidissima e spettacolare industrializzazione, ed è altresì risaputo ch’essa vide la folgorante ascesa dei ceti più umili alle massime cariche governative e partitiche. Ma la cosiddetta «promozione sociale» (vydviženie) fu accompagnata dal ritorno della servitù della gleba (abolita nel 1861), e dall’introduzione del lavoro schiavistico (da tempo ignoto al mondo occidentale). Sia l’una che l’altro risultarono essenziali per l’edificazione del sistema industriale sovietico, e vennero aboliti soltanto dopo la morte di Stalin. Le radici del totalitarismo sovietico vanno cercate, oltre che nel predominio del partito unico e nel selvaggio terrore poliziesco, nella nascita d’una società inedita, a prima vista ultramoderna ma per molti aspetti arcaica e premoderna.
Tutti i regimi totalitari del XX secolo presentano tratti vistosamente arcaici accanto ad aspetti moderni (persino ultramoderni). Arcaismo e modernità li ritroviamo, per fare un esempio, anche nella Germania nazista. Le apparenze non devono trarre in inganno. Sebbene il Mein Kampf e la dottrina hitleriana siano pervasi di cupe nostalgie arcaizzanti (si pensi al culto degli antichi germani), il regime nazista non volle o non seppe ricacciare indietro la Germania. Anzi, per paradossale che ciò possa sembrare, il Terzo Reich (parlo dei territori tedeschi, non di quelli occupati) continuò a modernizzarsi e fece un ulteriore passo avanti nel processo, tipico delle società contemporanee, di «nazionalizzazione delle masse» e di omologazione sociale: la «comunità del popolo» (Volksgemeinschaft) hitleriana non fu solo un orpello ideologico del regime e un ritornello della propaganda nazista. Malgrado l’impegno profuso, i nazisti non fecero in tempo a distruggere la cultura e la tecnologia tedesche: sebbene la «scuola dei barbari» (per usare le parole di Erika Mann) rappresentasse un pauroso arretramento rispetto al formidabile sistema d’istruzione, che aveva consentito i grandi progressi della scienza e della tecnica tedesche, il rozzo modello pedagogico del Mein Kampf non poté essere applicato fino in fondo. L’esperimento nazionalsocialista portò sofferenze e lutti inenarrabili fuori della Germania, senza riuscire a sconvolgere l’assetto economico, antropologico e culturale della società tedesca. Il bolscevismo, invece, ad onta della conclamata ideologia prometeica e superindustrialistica, produsse effetti devastanti con i suoi forsennati e prolungati esperimenti d’ingegneria economica e sociale, ricacciando la Russia indietro di secoli e spezzando i legami che l’impero zarista aveva faticosamente annodato con la civiltà occidentale nei decenni anteriori al 1917.
Il comunismo sovietico è stato dunque, al di là delle apparenze, una gigantesca reazione, nel senso letterale dell’espressione, poiché ha bloccato una serie di processi in atto nella società russa tra Otto e Novecento. Nei suoi studi sullo sviluppo economico russo nell’età moderna e contemporanea, Alexander Gerschenkron costruì un affascinante modello interpretativo, che metteva in rilievo come soltanto il «grande slancio» (big spurt) di fine Ottocento fosse riuscito a mutare i caratteri generali dello sviluppo economico dell’impero zarista (contraddistinto da periodici e massicci interventi statali, volti a modernizzare il paese per fini strategico-militari lasciando quasi inalterata la struttura della società), e ad avvicinare finalmente la Russia ai paesi più progrediti dell’Europa occidentale. La rivoluzione bolscevica del 1917 interruppe bruscamente il processo d’occidentalizzazione, riportando in auge il vecchio modello statalistico e bellicistico introdotto da Pietro il Grande [1]. Una siffatta ricostruzione ha certamente alcuni punti deboli: v’è in essa la tendenza ad esagerare l’occidentalizzazione della Russia all’inizio del XX secolo; e, inoltre, si sopravvaluta il peso del retaggio autocratico nella storia dell’Urss, con il rischio d’ignorare o trascurare gli aspetti di «modernità» del totalitarismo sovietico (quali la nascita d’una società di massa e l’uso delle più raffinate tecniche pubblicitarie). Tuttavia, è indubitabile che la rivoluzione bolscevica annientò i germi di civiltà economica e giuridica attecchiti nel mondo russo nella seconda metà dell’Ottocento, impedendone la lenta e difficile maturazione.
Più in generale, è lecito affermare che il comunismo sovietico rappresentò una seria minaccia per il socialismo europeo e per le conquiste politico-sindacali dei lavoratori. Nel romanzo storico di cassetta Il secolo breve Hobsbawm ha tentato di ridare dignità scientifica alla leggenda secondo cui il comunismo moscovita, pur fallendo in casa propria, con la sua presenza sulla scena mondiale avrebbe costretto il capitalismo occidentale a modificarsi e ad umanizzarsi. Si può capire che un personaggio come Hobsbawm, per tutta la vita fervente estimatore dei partiti e dei regimi comunisti, dopo il naufragio dell’Urss si sia affrettato ad allestire una zattera di salvataggio per sé e per gli altri «compagni di strada». La sua furbesca operazione politico-culturale ha sortito l’effetto desiderato, a giudicare dal successo arriso al mediocrissimo libro (specie in Italia, dove sono ancora tanti i nostalgici del comunismo, comunque camuffati). Del resto, la favola narrata da Hobsbawm non è neppure farina del suo sacco: essa fu inventata anni fa dagli storici «progressisti» britannici Geoffrey Barraclough ed Edward H. Carr. La verità storica è un’altra. Nell’Europa occidentale, tra Otto e Novecento, la nascita di partiti socialisti di massa e la legislazione sociale cominciarono a modificare gli equilibri interni e lo stesso sistema capitalistico. A proposito dell’inarrestabile ascesa della socialdemocrazia tedesca, che all’inizio del XX secolo stava mutando l’assetto politico-sociale del Reich guglielmino, Élie Halévy formulò nel 1929 un’acuta ipotesi, sulla quale val la pena riflettere: «L’historien est en droit de se demander si une des raisons – nous sommes loin de dire la principale raison – qui décida l’aristocratie militaire allemande, en juillet 1914, à courir le risque d’une guerre européenne, ce ne fut pas le malaise croissant que lui faisait éprouver la pression grandissante du parti social-démocrate» [2].
La rivoluzione bolscevica produsse colossali effetti reazionari anche nel generale assetto geopolitico del continente eurasiatico. In che senso? Il partito di Lenin, ad onta della sbandierata ideologia internazionalistica, riuscì non solo a fermare il processo di disgregazione del vasto e anacronistico impero zarista, ma altresì a ridar forza al vecchio imperialismo russo. La rinascita dell’imperialismo granrusso fu il più concreto e duraturo risultato dell’azione di governo dei comunisti, quello che ha maggiormente contribuito a cementare l’etnia dominante della società sovietica, compensandola, con l’orgoglio patriottardo, delle tremende vicissitudini e tribolazioni prodotte dall’«edificazione del socialismo». Crollato, dopo una lunga fase di putrescenza, il sistema economico e politico sovietico, alla popolazione granrussa oggi non è rimasta che la nostalgia della potenza imperiale del periodo comunista. L’odierno tatarofascismo (lo chiamerei così, per distinguerlo da altri tipi di fascismo), affermatosi in Russia dopo l’incerto interregno di El’cin, è l’erede dell’imperialismo bolscevico e zarista. Che il comunismo sovietico, dopo decenni di convulse e atroci vicende, abbia lasciato in retaggio all’umanità una delle più pericolose e aggressive forme di fascismo, dovrebbe far riflettere quanti ancor oggi si ostinano a nutrire illusioni circa la natura del tatarocomunismo novecentesco. Con tale termine, che potrà ferire molte orecchie pudiche, ma che evoca con efficacia la sua natura barbara e aggressiva, e ricorda altresì il paese che ne fu la culla, andrebbe designato il comunismo del XX secolo; un termine che, in ogni caso, è preferibile a quello edulcorato e insulso di «comunismo reale» (o «comunismo realmente esistente»). Dal tatarocomunismo al tatarofascismo: è stata questa l’amara parabola storica della Russia dal 1917 ad oggi.
Come ha potuto il partito bolscevico, il quale alla vigilia del 1917 non era che una piccola setta politica, generare così grandi e sconvolgenti mutamenti economico-sociali e geopolitici? Ciò fu possibile non solo grazie alla fermissima determinazione di Lenin e dei suoi seguaci, ma anche (e soprattutto) a causa dell’immane cataclisma sociale dell’autunno 1917. Come dicevo all’inizio del mio intervento, è l’azione combinata di entrambe le forze – bolscevismo e rivoluzione plebea – che ha forgiato l’Urss e la società sovietica. Sul bolscevismo mi sono soffermato sin troppo, con una digressione che spero non venga giudicata arbitraria e inopportuna. Debbo ora parlare della rivoluzione plebea, che è poi il tema assegnatomi. Vorrei dire, a mo’ di premessa, che la rivoluzione plebea fu un aspetto fondamentale della rivoluzione russa, il suo momento più dinamico, che culminò – ma non si esaurì – nella vasta e furiosa jacquerie contadina dell’autunno 1917. Per meglio chiarire il mio approccio alla questione, ho bisogno di altre digressioni storiche, che mi porteranno lontano dai confini della Russia e dalle vicende del secolo appena conclusosi. Spero che il lettore voglia, ancora per un po’, mostrarsi paziente e indulgente con me. Per rivoluzione plebea intendo la forma più radicale, primitiva, estrema e violenta di lotta di classe. «La storia di ogni società esistita fino ad oggi è storia di lotte di classe». La lapidaria sentenza si trova, come ognuno sa, nel Manifesto del partito comunista di Marx ed Engels. Non occorre esser convinti adepti del materialismo storico per accettare il nocciolo di verità racchiuso nella frase testé citata. Sebbene la storia umana non possa esser tutta spiegata con l’azione della lotta di classe, non si può negare che i conflitti sociali (più o meno violenti) ne siano stati uno dei motori principali. Dovrei ora costruire una sia pur rozza e provvisoria tipologia delle lotte sociali nella storia occidentale, per potervi collocare la rivoluzione plebea russa.
Perché mai è necessario, per comprendere la rivoluzione russa (in particolare, il suo momento plebeo), accennare ad analoghi fenomeni nella storia occidentale, non solo contemporanea? Ciò serve, come si vedrà, a mostrare il carattere essenzialmente premoderno della rivoluzione sociale culminata nell’autunno 1917. Ma, per far ciò, occorre ipotizzare una fondamentale unità della storia occidentale dalla Grecia antica ai giorni nostri, una storia con caratteri peculiari e in ogni caso diversi da quelli che contraddistinguono altre civiltà umane (la Cina, il mondo arabo o l’America precolombiana). Il tema è talmente sconfinato e controverso, che può sembrare follia anche solo farne cenno. Eppure, io sono persuaso che il modello unitario della storia occidentale, se costruito con intelligenza e adoprato con cautela, possa diventare un fruttuoso strumento euristico. In fondo, gli storici della filosofia o del pensiero politico sono avvezzi (o dovrebbero esserlo) a passare agevolmente da Platone a Kant, da Aristotele a Locke, da sant’Agostino a Vico. Perché gli altri storici debbono invece trincerarsi nel piccolo fortino di loro spettanza, rifiutandosi d’esplorare i territori circostanti? E’ vero che lo studio dell’economia, dei conflitti politico-sociali o delle istituzioni è meno semplice della lettura dei classici del pensiero. Ma chi studia le guerre civili nel mondo contemporaneo può permettersi d’ignorare le penetranti e attualissime riflessioni di Tucidide sulla guerra civile a Corcira? Oggi molti sembrano aver dimenticato le radici della nostra storia e della nostra civiltà. Accade persino, in virtù dei nostri balzani e gretti programmi universitari, che ci si laurei in storia contemporanea, essendo digiuni di storia greca e romana, e in storia antica ignorando quella moderna e contemporanea!
Che cosa vuol dire costruire un modello unitario di storia dell’occidente? Oltre che ardua, l’impresa non è scevra di rischi e insidie. Quale esempio d’approccio brillante ma poco fecondo, voglio citare la teoria del «comune modello umano» (Algemeen Menselijk Patroon) di Jan Romein, il quale tentò di spiegare ciò che distingueva il mondo occidentale dopo il Rinascimento da tutte le altre società umane, situando il momento di brusca e radicale svolta nell’Europa quattro e cinquecentesca [3]. Il vecchio continente si sarebbe distaccato, all’improvviso, dal «comune modello umano», al quale anch’esso aveva appartenuto fino allora, e avrebbe intrapreso la sua inarrestabile espansione economica e coloniale. Non ha molto senso, a mio parere, ravvisare la novità e l’originalità della storia occidentale solo a partire dal XV secolo dell’era cristiana; lo stesso Romein, del resto, senza quasi accorgersi della contraddizione, individuava furtivi momenti di rottura dello statico e rigido modello, comune a tutte le civiltà umane, già nel Medioevo occidentale e nell’antichità greco-romana. Più sensato e fruttuoso mi pare invece lo sforzo, compiuto da David S. Landes, d’indagare sulle lontane premesse della rivoluzione industriale, da lui cercate nella precedente storia del Medioevo europeo. Le pagine introduttive del Prometeo liberato, riprese e ampliate nella Storia d’Europa Einaudi [4], mostrano come una svolta epocale della storia occidentale (e mondiale) quale la rivoluzione industriale (che pur Landes considera, a ragione, un radicale evento rivoluzionario) possa essere intesa appieno solo nel più ampio contesto d’una millenaria tradizione socio-culturale, diversissima – per esempio – da quella del mondo arabo (basti pensare agli effetti dell’invenzione della stampa in Europa e nei paesi islamici).
Io mi spingerei ben oltre il pur ardito approccio di Landes, comprendendo nel modello di storia occidentale, senz’alcuna esitazione, l’antichità classica e la tradizione giudaico-cristiana. In ogni caso, la tipologia (sia pur provvisoria e schematica) delle lotte politico-sociali nel mondo occidentale, che sto per abbozzare e che ci serve per situare e comprendere la rivoluzione russa, non può escludere i conflitti accaduti ad Atene e a Roma, poiché essi ebbero alcuni caratteri ravvisabili anche in successivi momenti della storia europea. Lotte di classe e scontri politico-sociali hanno avuto luogo in tutta la storia umana. Tuttavia, uno dei tratti distintivi dei conflitti nel mondo classico fu, mi pare, la peculiarissima interazione di cambiamenti politici e lotte sociali. Ad Atene e nella Roma repubblicana furono inventate le prime complesse forme di rappresentanza politica degl’interessi economici e sociali: in altre parole, le lotte di classe furono sovente accompagnate dalla nascita non solo di oligarchie e fazioni politiche, ma anche di autentici partiti (o, comunque, di gruppi organizzati somiglianti agli odierni partiti). Già allora i conflitti sociali erano accompagnati da vivaci lotte politiche, che portavano spesso ad un generale mutamento degli equilibri – sociali e politici – esistenti. Da allora e fino alla nostra epoca il cammino delle società occidentali è stato scandito da guerre di classe, da conflitti di gruppi politici organizzati, da crisi rivoluzionarie e da azioni riformatrici (mi sia consentito far ricorso ad una terminologia mutuata dalla storia moderna e contemporanea). Le rivoluzioni e le riforme – che troviamo in tanti momenti della storia occidentale, a partire dall’antichità classica – sono dunque aspetti essenziali della tipologia dei conflitti politico-sociali, che sto qui abbozzando.
Una categoria di lotte sociali, che possiamo considerare irrilevante per la nostra analisi, è costituita dai conflitti per così dire fisiologici, ossia connaturati ad un dato sistema economico-sociale: ad esempio, le rivolte contadine, entro certi limiti, fanno parte del funzionamento del sistema signorile, così come gli scioperi operai sono connaturati alla moderna impresa industriale (l’osservazione, com’è noto, è di Marc Bloch).
Più da vicino c’interessano ora quelle che chiamiamo abitualmente riforme politico-sociali, cioè le misure legislative che modificano profondamente gli equilibri preesistenti nella distribuzione del potere e della ricchezza tra le classi e i ceti. Si tratta spesso di autentiche rivoluzioni, perché nascono solitamente da corposi movimenti o esigenze della società ed hanno effetti durevoli (pur non essendo accompagnate necessariamente da guerre intestine e da cataclismi interni). Nel mondo contemporaneo, l’azione di governo dei partiti socialdemocratici in Scandinavia e in Gran Bretagna è stato l’esempio più vistoso e lampante di riforme attuate in collegamento con larghi settori della società. Eventi consimili non mancarono nell’antichità classica. Ricordo almeno le incisive riforme di Clistene, le quali, sostituendo le tribù gentilizie con quelle territoriali, gettarono le basi della democrazia ateniese. La fine del VI secolo ad Atene fu un periodo di grandi turbolenze sociali, accompagnate anche dall’intervento straniero (il re spartano Cleomene giunse in soccorso del conservatore Isagora): uno scenario che ricorda molto da vicino le rivoluzioni e le guerre civili del mondo contemporaneo. Con le sue ardite misure democratiche, Clistene (che io non esiterei a definire il più grande riformatore della storia occidentale) seppe dare uno sbocco positivo e costruttivo alla grave crisi politico-sociale del suo tempo [5].
Ci sono poi le riforme dall’alto, realizzate cioè per iniziativa di sovrani o governanti assoluti e illuminati. A dire il vero, tali azioni non sono prerogativa della storia occidentale, perché s’incontrano di frequente in altre civiltà. Se si vuol indagare sui caratteri peculiari della storia occidentale, non si possono ignorare gli aspetti che l’accomunano ad altri mondi storici. Come che sia, anche le riforme dall’alto hanno avuto sovente effetti rivoluzionari, producendo vistosi e repentini mutamenti nella società o imprimendo una forte accelerazione ai processi evolutivi in corso. Gli esempi sono innumerevoli, dal mondo antico fino al riformismo settecentesco. Mi sia permesso di ricordare un tentativo riformatore che, se non fosse stato stroncato dalla morte del suo artefice, avrebbe prodotto un terremoto nella società italiana del VI secolo. Si tratta delle ordinanze con le quali, come sappiamo da Procopio di Cesarea, il re ostrogoto Totila ordinò ai coloni e ai fittavoli di pagare canoni e tributi non più ai proprietari terrieri e al demanio imperiale, ma a lui direttamente. Gli storici si son sempre divisi sugli obiettivi e sulla portata di tali provvedimenti che, secondo alcuni, erano tali da produrre una profonda rivoluzione nei rapporti di proprietà, e secondo altri vanno letti solo come un’abile mossa di propaganda nella guerra tra goti e greci. Oggi i più seguono quest’ultima interpretazione, guardando con scetticismo alle intenzioni e agli effetti degli editti di Totila [6]. L’altro punto di vista, che a me pare più plausibile, fu strenuamente difeso, tra gli altri, da Pasquale Villari [7]e da Corrado Barbagallo [8]. Certo è che la Prammatica sanzione di Giustiniano condannò il «tiranno Totila», abolendo tutte le sue disposizioni e conservando quelle degli altri re ostrogoti. Credo pertanto che sia lecito sottoscrivere il ponderato giudizio di Gino Luzzatto: «Totila pensò di raggiungere il doppio vantaggio di indebolire il nemico e di assicurarsi il favore ed il concorso dei lavoratori dei campi, dispensando i coloni dall’obbligo di corrispondere ogni censo, prestazione o tributo ai loro signori, pagando direttamente al fisco ostrogoto soltanto ciò ch’essi dovevano a titolo d’imposta. Se, come sembra, è questa l’interpretazione esatta dei passi di Procopio, che ci han conservato, in forma molto concisa, il ricordo del provvedimento di Totila, non v’ha dubbio che da quelle disposizioni, nonostante il loro carattere di semplice strumento di guerra e di propaganda, avrebbe potuto derivare una vera rivoluzione nella situazione sociale ed economica della terra» [9].
Nella storia della Russia moderna e contemporanea le riforme dall’alto svolsero un ruolo essenziale nell’occidentalizzare il paese. Ma non fu, come si continua a ripetere, Pietro il Grande ad avvicinare l’arcaica e barbara Moscovia all’Europa. Le sue riforme, esteriori e artificiose, valsero solo a copiare dai paesi più evoluti dell’occidente una serie di conquiste tecniche e taluni modelli amministrativi, lasciando immutata la struttura della società. Più feconde e incisive si rivelarono le riforme di Alessandro II, che svecchiarono il paese mettendo in moto un sia pur faticoso e lento processo d’ammodernamento. Non parlo dell’abolizione del servaggio, che non risolse nessuno dei drammatici problemi delle campagne e si rivelò foriera di sciagure. La riforma meglio riuscita fu quella giudiziaria del 1864, che introdusse i principi della moderna civiltà giuridica e contribuì a creare un vasto ceto di colti uomini di legge e avvocati. Importante fu anche la nascita delle amministrazioni provinciali e distrettuali (gli zemstva), i cui impiegati (i membri del cosiddetto «terzo elemento») costituirono un’importante novità nella struttura della società russa. I medici condotti, i maestri elementari, gli agrimensori e gli altri tecnici e intellettuali degli zemstva svolsero l’importante compito di migliorare le condizioni di vita ed elevare il livello d’istruzione dei ceti popolari, costruendo un ponte tra la Russia colta e occidentalizzante e l’arcaico mondo plebeo. Dal «terzo elemento» provenivano non pochi militanti e simpatizzanti dei gruppi liberali e populistici, che tanta parte ebbero nella rivoluzione del 1905. Sin dall’età di Pietro il Grande l’intellighenzia occidentalizzante si rivelò l’elemento più inquieto e dinamico della società russa, anche perché era, per molti versi, una sorta di awkward class (per usare la formula con la quale, in un celebre libro, Teodor Shanin designò i contadini [10]): sorta e cresciuta per iniziativa del regime autocratico, che necessitava d’un ceto di tecnici e funzionari istruiti, essa subiva il fascino dell’occidente e sentiva il disagio e la frustrazione di dover operare in un contesto politico-sociale arretrato e lontanissimo dai suoi ideali. A partire dalla seconda metà dell’Ottocento, grazie anche alle riforme di Alessandro II, l’intellighenzia venne sempre più avvicinandosi al mondo popolare e a farsene interprete. Il momento in cui essi quasi si toccarono fu la rivoluzione del 1905, che dev’essere vista come una grande possibilità mancata d’immettere le masse plebee russe nella civiltà moderna. Il tentativo naufragò non per colpa dell’intellighenzia rivoluzionaria, come pensa Richard Pipes, ma per la precipua responsabilità del regime zarista, incapace di rinnovarsi e modernizzarsi. Le due Russie restavano comunque distanti, come mostrò il furore patriottico dei ceti medi e intellettuali esploso con la prima guerra mondiale: l’intellighenzia, che nel 1905 s’augurava la disfatta della Russia nella guerra con il Giappone, dopo il 1914 si levò tutta (o quasi tutta) in difesa della scelta bellicistica del governo zarista, rimproverando semmai a quest’ultimo l’incerta e maldestra conduzione delle operazioni militari. La prima guerra mondiale mostrò l’abisso che ancora divideva i due mondi. Inasprita e incattivita dalla dura vita in trincea e nelle retrovie, la Russia contadina e plebea nell’autunno 1917 diede vita ad una delle più violente e cupe guerre sociali che la storia umana ricordi.
Ma prima di descrivere la rivoluzione plebea del 1917, devo dire qualcos’altro sulla tipologia delle lotte sociali nella storia occidentale. Il problema di cui adesso va fatto cenno è quello del livello di consapevolezza politica delle rivolte sociali. I tumulti sociali e annonari, così frequenti nel Medioevo e nell’età moderna, furono sempre rivolte cieche e spontanee? E i moti sociali del mondo contemporaneo sono da catalogare tutti, o quasi tutti, quali azioni dotate d’un certo grado di coscienza politica? Il problema non è semplice. Basta comparare la rivolta di Perugia, la «sommossa del Bruco» a Siena (entrambe del 1371) e il più celebre tumulto dei Ciompi di pochi anni dopo, per vedere come movimenti sociali simili avessero livelli di maturità ed esiti politici alquanto diversi tra loro. Prendiamo ancora la rebeine di Lione del 1529, che a prima vista sembra una tipica rivolta frumentaria. In realtà, il termine stesso rebeine sta a indicare una peculiare tradizione di ribellione popolare e presuppone una certa consapevolezza sociale e politica. Come mostrarono i fatti del 1529, non si trattò d’un semplice tumulto annonario: «la folla si radunò sul luogo destinato alle assemblee municipali e di qui si mosse per aprire il granaio del comune e prelevare grano dalle ampie scorte dei ricchi: misure, queste, già prese in passato dal consiglio cittadino, ma che non erano state attuate tempestivamente in quella crisi» [11].
I moti sociali del Medioevo e dell’età moderna racchiudono, in tanti casi, imprevedibili elementi di consapevolezza politica. All’inverso, non poche rivolte e sommosse del mondo contemporaneo, avvenute anche dopo la nascita dei sindacati e dei partiti di massa, ad una più attenta indagine rivelano tratti arcaici e premoderni. Mi limito a citare l’episodio dei fasci siciliani, per il quale mi pare ancor valido il giudizio che Salvemini ne diede, a caldo, pochi anni dopo quei drammatici fatti: «La jacquerie del ’93 fu una convulsione isterica, nella quale il socialismo ci entrò solo perché, essendovi nel resto del mondo un partito socialista rivoluzionario, questi affamati saccheggiatori di casotti daziari credettero di essere socialisti anche essi» [12]. Ma ancor meglio dell’aspro e polemico giudizio storico-politico di Salvemini, ci aiuta a cogliere la reale natura di quella tragedia siciliana la splendida e commossa rievocazione fatta da Pirandello in alcune pagine del romanzo I vecchi e i giovani (che è, io credo, una geniale raffigurazione dei drammi morali, politici e sociali dell’Italia postunitaria).
Sbocchi riformatori di vasti movimenti sociali, ardite riforme realizzate dall’alto, moti popolari spontanei e rivolte con un sufficiente grado di consapevolezza politica: sono questi i principali tipi di conflitti e di crisi politico-sociali che son venuto finora elencando. Della rivoluzione plebea dicevo, all’inizio del mio discorso, che è la forma più primitiva e violenta di lotta di classe. Non poche sono state le rivolte cupe e selvagge, propagatesi su un ampio territorio, devastanti e distruttive, ma prive di sbocchi politici. I reietti della società si sono sollevati periodicamente, nel disperato tentativo di cambiare la loro condizione; ma, non trovando alcuna forma d’espressione o rappresentanza politica né possedendo quella che noi chiameremmo cultura di governo, tali insurrezioni sono state sempre votate all’insuccesso. Le rivolte degli schiavi nel mondo antico costituiscono una tipica manifestazione di tale forma estrema di lotta di classe. Accennerò un attimo ad una di esse, cioè all’insurrezione che ebbe luogo in Sicilia nel 135-132 a.C., perché il minuzioso racconto compilato da Diodoro Siculo (di cui restano copiosi sunti e frammenti) ci consente di penetrare all’interno del mondo dei rivoltosi, e anche perché essa presenta sorprendenti analogie con le grandi jacqueries della storia russa. In Sicilia lo schiavo siriaco di nome Euno si pose alla testa dei suoi compagni di sventura, proclamandosi Antioco re di Siria e circondandosi d’una buffa corte. Una consimile scimmiottatura della cultura ufficiale la ritroviamo nella famosissima rivolta di Pugačëv, il quale, com’č risaputo, disse d’essere lo zar Pietro III e volle imitare lo stile burocratico-cancelleresco dei manifesti imperiali. Eppure, sia lo schiavo siriaco che il ribelle cosacco si rivelarono abilissimi e sanguigni capipopolo, oltremodo bravi nel guidare e spronare i loro seguaci: Euno organizzò persino spettacoli teatrali, nei quali veniva messa in scena la triste condizione servile; e Pugačëv seppe conquistarsi il favore delle popolazioni musulmane e delle sette religiose dei «vecchi credenti», promettendo loro libertŕ di culto. Ma né l’uno né l’altro seppero far a meno di copiare goffamente i modelli politico-culturali delle classi dominanti.
La storia della Russia moderna e contemporanea è stata scandita da periodiche esplosioni della collera contadina: di siffatte primitive jacqueries la più nota, ma non certo l’unica, fu la rivolta di Pugačëv (la cosiddetta pugačëvščina, che parve mettere a repentaglio il trono di Caterina II). La rivoluzione sociale dell’autunno 1917 fu una pugačëvščina non meno selvaggia e primitiva dell’apocalittica epopea contadina del 1773-1774, e di dimensioni ancor più vaste. Tenute nobiliari saccheggiate e incendiate, amministratori e proprietari trucidati o costretti a fuggire: un ferocissimo terrore agrario s’abbatté in special modo nella regione delle terre nere e nelle province bagnate dalla Volga. L’apocalittica ordalia contadina durò alcuni mesi, dall’inizio dell’autunno 1917 fino al gennaio 1918. In quel periodo i mugichi furono gl’incontrastati padroni delle campagne russe, dove imposero la loro legge, sottraendosi all’influenza politica di qualsiasi partito. Neppure i bolscevichi ebbero voce in capitolo in quei mesi di terribile caos, se si eccettua il ruolo svolto dai soldati tornati dal fronte, i quali attizzarono il fuoco dell’incendio sociale nei villaggi interpretando a modo loro talune parole d’ordine del partito di Lenin. Molti militari di truppa, abbandonate le trincee grazie anche alla propaganda disfattistica dei bolscevichi, diedero il loro rude contributo alla guerra contadina. Ma gli agitatori bolscevichi, cresciuti in ambiente urbano, non avevano né la forza numerica né la capacità politica di guidare lo spontaneo movimento agrario. Più che suscitare e dirigere l’insurrezione contadina, il partito di Lenin seppe assecondarla con il famoso «decreto sulla terra», il quale ebbe sì un grande valore simbolico e politico, ma modestissimi effetti pratici. Anche dopo il 26 ottobre 1917 i contadini seguitarono a farsi giustizia da sé e ad impadronirsi dei beni, delle scorte e degli attrezzi dei grandi proprietari. Soltanto la successiva legge sulla «socializzazione della terra» del 27 gennaio 1918, elaborata e messa in atto sotto la guida dei socialisti rivoluzionari di sinistra (i quali avevano il controllo del commissariato del popolo per l’agricoltura), riuscì a pacificare le campagne avviando quella grandiosa riforma egualitaria che, da tempi immemorabili, era nei sogni dei mugichi.
Mentre era in corso la grande guerra contadina, altre forme violente ed estreme di protesta sociale avevano luogo in Russia. I soldati e i marinai, stanchi del lungo conflitto, si ribellavano rivolgendo talora le armi contro i loro comandanti. Nei centri urbani gli operai prendevano possesso in maniera disordinata delle fabbriche, usando violenza contro proprietari e personale tecnico-direttivo (l’ingegnere portato in giro sulla carriola divenne il simbolo materiale dell’odio di classe proletario) e tentando, quasi sempre con scarsi risultati, di far funzionare gl’impianti. In tali forme di lotta è facile scorgere lo zampino degli agitatori bolscevichi, popolarissimi nelle caserme e nelle fabbriche. Eppure, nell’autunno 1917 essenzialmente plebea (ossia, spontanea e primitiva) fu anche la rivoluzione urbana. I pubblicisti e gli storici si son lasciati attrarre più del lecito dalle manifestazioni di maturità politico-sociale dei lavoratori e dei soldati (che certo non mancarono), chiudendo gli occhi dinanzi ai numerosi episodi meno edificanti. Nella maggior parte dei casi, specie nei piccoli centri di periferia, la protesta dei ceti più umili assunse forme anarchiche e selvagge. Prova ne è, fra l’altro, il diffusissimo fenomeno delle ubriacature e delle violenze collettive, che neppure i soviet erano in grado di arginare. Persino a Pietrogrado, nella leggendaria fortezza del bolscevismo, l’insurrezione d’ottobre fu accompagnata da assalti a depositi di bevande alcoliche, da pantagrueliche ubriacature, da furti di opere d’arte e da altre manifestazioni di squallida violenza.
In un articolo apparso nel 1977 sul settimanale del Pci «Rinascita» e ripreso in una successiva raccolta di saggi, lo storico cecoslovacco Michal Reiman sollevò la questione del rapporto tra rivoluzione liberale e rivoluzione plebea nel 1917, definendo gli eventi del febbraio-marzo 1917 «un curioso intreccio di rivoluzione borghese immatura dell’era moderna e di rivoluzione plebea russa» [13]. Le forze borghesi e liberali, strutturalmente deboli ma pur attive fino alla primavera, furono sommerse e travolte dal prorompente movimento plebeo, affermatosi in autunno. L’acuta intuizione di Reiman merita d’esser sviluppata e approfondita. Perché trionfò la rivoluzione plebea? A differenza delle precedenti jacqueries, quella dell’autunno 1917 non solo fu più vasta, ma avvenne in concomitanza con altri movimenti plebei e coincise con l’insurrezione lanciata da un partito politico di rivoluzionari di professione. Il terremoto plebeo che distrusse i germi di civiltà moderna, sbocciati in Russia dopo il 1861, e che per tanti aspetti somigliava alle cupe e selvagge esplosioni sociali del passato, fu accompagnato dall’azione per così dire parallela del bolscevismo. Ebbe luogo, insomma, un’immane pugačëvščina, che vide emergere non un novello Pugačëv, bensě Lenin.
Qualunque sia il giudizio storico-politico su Lenin e sul partito da lui fondato, una cosa è certa: per la sua visione programmatica e prassi politica il bolscevismo apparteneva alla grande famiglia del socialismo europeo e russo, cioè ad un movimento politico-sociale le cui radici affondavano nel mondo contemporaneo, emerso dalla rivoluzione industriale e dalla rivoluzione francese. Non importa adesso indagare sulle reminiscenze ottocentesche e finanche giacobine della concezione di Lenin, più vicina al mondo elitario delle società segrete e delle congiure che alla società di massa sorta tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo. Il bolscevismo era pur sempre un movimento politico cosciente, guidato da intellettuali colti. Giova meglio far qui menzione d’una componente del leninismo, rivelatasi un prodigioso strumento d’azione nell’autunno 1917: il bakunismo sociale. Nella tradizione rivoluzionaria ottocentesca era stato il fondatore dell’anarchismo a insistere, con vigore, sull’azione creativa delle masse e sul ruolo positivo di qualsiasi forma di ribellismo popolare. Pur provenendo da una ben diversa formazione politica, sin dal 1905 Lenin fece sue tali idee di Bakunin, senza neppure rendersi conto che esse cozzavano con la propria concezione del partito. In ogni caso, ciò gli permise di coglier subito, nell’autunno 1917, l’immensa forza eversiva della jacquerie contadina.
Giunto al potere grazie soprattutto alla grande sollevazione plebea, il partito bolscevico si mostrò sulle prime in sintonia con i desiderata delle masse popolari urbane e rurali. I decreti sulla terra, sulla pace e sul «controllo operaio» parvero cementare l’alleanza tra bolscevichi e mondo plebeo. Finché i socialisti rivoluzionari di sinistra, eredi della tradizione populistica, assicurarono il loro sostegno al nuovo governo mediando tra bolscevichi e mondo contadino, il potere sovietico ebbe il sostegno delle campagne. Poi, a partire dalla primavera 1918, cominciò la guerra tra stato bolscevico e mugichi. L’ideologia leninista era troppo lontana dall’universo contadino perché fosse possibile un’intesa tra il partito al potere e gli abitanti delle campagne. Saliti al potere quali interpreti della volontà contadina, i bolscevichi tentarono d’annullare o di stravolgere molti risultati della rivoluzione agraria del 1917-1918.
Una così tragica contraddizione segnò l’intera storia dell’Urss. I bolscevichi, i quali dovevano la loro vittoria al terremoto plebeo del 1917, per realizzare il loro programma non esitarono a straziare orribilmente le masse popolari, come nessun governo monarchico o borghese avrebbe osato fare. Eppure, la rivoluzione plebea lasciò la sua impronta indelebile sul bolscevismo, la cui composizione sociale subì una rapida metamorfosi dopo il 1917, e sullo stesso stato sovietico, trasformatosi anch’esso profondamente negli anni ’30. La contraddizione fu massima proprio sotto Stalin, massacratore della vecchia guardia bolscevica d’estrazione piccolo-borghese, fautore d’una classista «promozione sociale», ma altresì inflessibile sterminatore dei mugichi. Durante l’era di Stalin, il quale fu il vero artefice del regime totalitario, massima risultò anche la commistione di modernità e arcaismo: industrializzazione a rotta di collo e asservimento dei contadini, «promozione sociale» e nascita d’una società divisa in caste, idolatria della tecnica occidentale e imbavagliamento della ricerca scientifica, scolarizzazione di massa e imbarbarimento della cultura. Stalin fu un tiranno capriccioso e crudele, fedele alla concezione elitaria del partito ereditata dal leninismo, ma dotato altresì d’un formidabile intuito che gli permetteva (senz’aver letto, a differenza di Mussolini e di Hitler, la Psychologie des foules) di cogliere taluni aspetti dell’odierna società di massa descritti da Gustave Le Bon.
Prima di chiudere il discorso, mi par utile un fugace cenno ad un’ultima questione. Ho finora presentato la rivoluzione plebea dell’autunno 1917 come un furioso e devastante ciclone sociale, quasi si sia trattato d’un ineluttabile cataclisma naturale. Per alcuni aspetti – anzitutto, per la sua violenza distruttiva – lo fu per davvero. Non si dimentichi, tuttavia, che nella storia umana non si danno eventi assolutamente inevitabili. La terrificante rivoluzione plebea fu preceduta, tra la primavera e l’estate del 1917, da una pacifica rivoluzione agraria promossa e organizzata dai socialisti rivoluzionari. Gli stereotipi sulla rivoluzione russa, fino a oggi imperanti anche tra gli storici di mestiere, hanno impedito di far piena luce su tale fenomeno, così come su altri episodi e aspetti del processo rivoluzionario. Non è possibile, in questa sede, spiegare che cosa fu e perché fallì il movimento agrario semilegale del maggio-giugno 1917. Vorrei però ripetere quanto detto all’esordio del mio intervento. La rivoluzione plebea e la rivoluzione bolscevica non furono che due momenti, ancorché fondamentali, del più vasto fenomeno storico chiamato rivoluzione russa. L’interpretazione della rivoluzione plebea e del bolscevismo, che ho qui offerto, andrebbe integrata e completata con un più ampio discorso su tutte le forze sociali e politiche operanti nella rivoluzione russa. Non mi è consentito, per ragioni di spazio, trattare adesso il complesso argomento. Basterà rammentare che sono ancora tanti, in questo campo di studi, i luoghi comuni da demolire e le leggende da sfatare.
NOTE
1- Oltre al profilo generale Modelli e problemi dello sviluppo economico russo: 1861-1958 (nella sua notissima raccolta di saggi Il problema storico dell’arretratezza economica, con prefazione di R. Romano, Torino, Einaudi, 1965, pp. 115-144), di Gerschenkron si vedano le quattro Ellen McArthur lectures del maggio 1968 (Lo sviluppo industriale in Europa e in Russia, Bari, Laterza, 1971) e lo studio scritto per la Cambridge Economic History of Europe (Politica agraria e industrializzazione in Russia, 1861-1917, in Storia economica Cambridge, VI.2 La rivoluzione industriale e i suoi sviluppi, a cura di H. J. Habakkuk e M. Postan, edizione italiana a cura di V. Castronovo, Torino, Einaudi, 1974, pp. 766-863).
2- É. Halévy, L’ère des tyrannies. Études sur le socialisme et la guerre, préface de C. Bouglé, postface de R. Aron, Paris, Gallimard, 1990, p. 176.
3- J.M. Romein, The Common Human Pattern (Origin and scope of historical theories), in «Cahiers d’Histoire Mondiale», IV (1958), pp. 449-463.
4- D.S. Landes, Radici sociali e culturali dello sviluppo europeo, in Storia d’Europa, V, L’età contemporanea. Secoli XIX-XX, a cura di P. Bairoch e E.J. Hobsbawm, Torino, Einaudi, 1996, pp. 117-144.
5- Sul rapporto tra Clistene e la «rivoluzione ateniese», lo studio più recente è il denso articolo di G. Camassa, Cronaca degli anni fecondi: Clistene, il demos e le eterie, in «Quaderni di storia», 2000, 51, pp. 41-56.
6- Ovidio Capitani (Storia dell’Italia medievale. 410-1216, Roma-Bari, Laterza, 1986, p. 31) ha scritto: «la legge sociale di Totila poté abolire di fatto la proprietà privata e lasciare i coloni sulla terra, poté dare un padrone anonimo ed unico ai contadini italici, poté umiliare i vecchi padroni, non migliorare una sorte tra le più disgraziate della storia». Sarebbe quindi «fuori di ogni verità e realtà il parlare – come pur si è fatto da molti – di “rivoluzione sociale”».
7- Secondo il quale Totila «s’appoggiava sul popolo, sui contadini e coloni, trattandoli meglio che poteva, accogliendo nel suo esercito gran numero anche di schiavi» (P. Villari, Le invasioni barbariche in Italia, Milano, Hoepli, 19284, p. 225).
8- Si leggano le pagine, ancor oggi avvincenti, ch’egli dedicò a Totila nella sua Storia universale: C. Barbagallo, Il Medioevo (476 sec. XI), parte prima, Torino, UTET, 1935, pp. 76-88.
9- G. Luzzatto, Storia economica d’Italia. Il Medioevo, Firenze, Sansoni, 19632, p. 46.
10- T. Shanin, The Awkward Class. Political Sociology of Peasantry in a Developing Society: Russia 1910-1925, Oxford, Clarendon Press, 1972.
11- N. Zemon Davis, Le culture del popolo. Sapere, rituali e resistenze nella Francia del Cinquecento, Torino, Einaudi, 1980, pp. 218-219.
12- G. Salvemini, Movimento socialista e questione meridionale, a cura di G. Arfé, Milano, Feltrinelli, 1968, p. 26.
13- M. Reiman, Lenin, Stalin, Gorbačev. Kontinuität und Brüche in der sowjetischen Geschichte, Hamburg, Junius Verlag, 1987, p. 16.